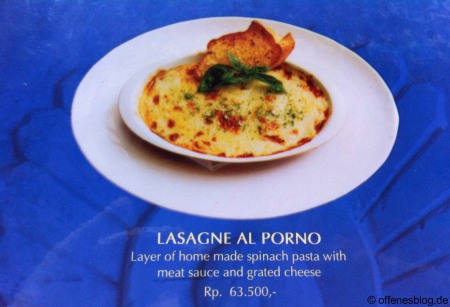Il biiiip prolungato della sveglia, subito associato al rabbioso: “Nooo… quanto la odio quella TUA sveglia dannata!” dell’elfa (perché la sveglia alle sei e mezza la chiede lei, ma poi è colpa mia quando suona) seguita dal consueto “Vai tu in bagno, così dormo ancora altri cinque minuti” mi strappa al calduccio della trapunta in piuma d’oca anche perché so che altrimenti ne verrei scalciato fuori da quella che vuole dormire ancora e secondo lei la disturbo. In realtà, ero sveglio da almeno mezzora intento ad ascoltare i rumori inconfondibili del vento che scrolla le foglie dei platani e degli autobus che ripartono al semaforo. Infatti, appena raggiungo un’accettabile postura da Homo erectus (non pensate male…) e ricevuto il consueto “Non camminare a piedi scalzi! Quante volte te lo devo dire?” di colei che dovrebbe dormire ma mi sorveglia vigile, scosto le tende, scruto nel buio interrotto a tratti dalla luce dei lampioni e ….“Cazzo, ma è tutto gelato giù in giardino…” . Che, detto così, non è proprio l’incipit più affascinante della letteratura italiana. Vista la giornataccia invernale andrebbe forse meglio il decadentismo dannunziano, con un bel: “Orsù, andiamo è tempo di migrare” a cui magari aggiungere “…e portare il bretone a pisciare” prima di iniziare la solfa del pastore che lascia gli stazzi e va per il tratturo antico al piano.
Il quale bretone, nel frattempo, anche se non l’ho ancora verificato, sicuramente avrà approfittato del favore della notte per acciambellarsi a dormire sulla Sacra Poltrona Proibita del mio studio, immerso tra le morbidezze dei cuscini di raso e il plaid scozzese. Perché il giovanotto, spiace dirlo, da cane ruspante dal bel profumo di sottobosco, nato per i campi fangosi e i sentieri di campagna, si sta imborghesendo a tal punto da doverlo avvisare che rischia il declassamento di Standard & Poors da cane da caccia AAA+ a cane da salotto AA, come un Chihuahua. E questo comporterebbe per default il fiocchettino vezzoso, il cappottino scozzese per l’inverno e il collarino con le pailettes luccicanti. Veda lui se gli conviene…
Siccome a pensar male si farà peccato, ma ci si azzecca quasi sempre, come mi affaccio nel salottino e accendo la luce scorgo un musetto spettinato e due occhioni assonnati colti in flagranza di reato che mi fissano con l’aria del: “Ah! sei tu? Ma che ore sono? Dormivo così bene..." . Appena gli indico sdegnato il suo tappetino sul pavimento dicendogli "Scendi subito da quella poltrona, che non è tua!" lui, dopo essersi stiracchiato e aver praticato una lunga abluzione delle parti intime (immagino per scherno nei miei confronti) scenderà. Una volta sceso, la sua mossa successiva sarà quella di mettersi ad abbaiare senza alcun motivo in corridoio finché Morena strillerà “Porta fuori quel povero cane!” e al mio angosciato “Ma siamo sottozero, mi congelerò…” arriverà l’immancabile “ Hai voluto avere il cane? Buona passeggiata…”. Il bretone mi guarderà con l’aria soddisfatta di chi dice “Hai visto? Se mi lasciavi sulla poltrona, non avrei abbaiato”.
Però, in realtà, occorre ammettere che il possedere un cane ti spalanca aspetti inesplorati della vita e ti fa scoprire nuove opportunità interessantissime. Cose tipo il vedere le luci dell’alba e i tramonti sui prati, infradiciarsi i piedi nella rugiada, attraversare sciami di zanzare camminando lungo i fossi e tremare di freddo con le prime gelate e il cane che emette nuvole di vapore dalle fauci come fosse un drago, slogarsi una caviglia sprofondando tra le zolle di un campo arato, venire inseguito da una coppia di gatti e disturbare coppiette nei parchi perché Whisky ha deciso che deve pisciare proprio sulla panchina dove stanno pomiciando. Insomma, tutto un nuovo mondo. Ma non solo, ci sono infatti anche delle possibilità inedite: per esempio, mi sono sempre chiesto perché la domenica mattina, quando puoi finalmente dormire, i Testimoni di Geova ti suonassero il campanello alle otto per farsi mandare affan… quando potevano benissimo farsi mandare affan… verso le undici con tutto comodo. Ora, alzandomi per tempo ed essendo per strada prima delle sette di mattina, so che posso suonare il campanello ad un Testimone di Geova e chiedergli se posso salire su un momento a rompergli i marroni con la Bibbia mentre è ancora in pigiama. Giusto il tempo di sapere dove abiti qualcuno di loro e lo farò.
Da ragazzo mi piacevano molto le “Tragedie in due battute” di Achille Campanile e i film di Antonioni sull’incomunicabilità (credo di essere uno dei pochi italiani ad aver visto tre volte Deserto Rosso). L'uscire con il cane con tutte le occasioni di nuovi incontri che comporta mi consente oggi di vivere in prima persona, non proprio in due battute ma quasi, delle vere tragedie dell’incomunicabilità umana, dove ti sembra che le tue parole scorrano leggere sulla pelle dell'altro come il vento, senza lasciar traccia e significati. Un po' come succede a volte con l'elfa che mentre le parlo di una cosa che mi sta a cuore, come una new entry tra le molteplici malattie che minerebbero la mia salute, pensa a tutt'altro e mi risponde con "Ricordami che dobbiamo pagare la bolletta del gas" o cose simili, tanto che ormai mi diverto a infilare improvvisamente nei miei discorsi frasi senza senso tipo "Abbiamo un cavallo verde in giardino" per vedere se si meraviglia o continua a seguire il corso dei suoi pensieri anche se ha l'aria di chi ti ascolta. Al bar dei cinesi dove vado a far colazione, per esempio, ho vissuto una lunga stagione di incomunicabilità con la vecchia titolare che, immagino su disposizioni del Partito per smaltire la deplorevole sovrapproduzione di una fabbrica dolciaria dello Szechuan, continuava a propormi fagottini di mele malgrado le chiedessi dei croissant con la marmellata. Poi il cambio di gestione, con l'arrivo della simpaticissima signora Susanna, che è sempre una cinesina, ma parla benissimo l'italiano e gestisce con grande professionalità il bar e i suoi clienti, ha risolto il problema di comunicazione.
Ma, in realtà, non del tutto perché all'interno del bar staziona spesso una persona con la quale proprio non riesco a comunicare. Si tratta un vecchietto che, se non fosse male in arnese, sembrerebbe la copia conforme, occhiali scuri compresi, di Lionel Twain, il miliardario eccentrico di "Invito a cena con delitto". Ogni volta che mi vede entrare si avvicina con fare furtivo e, dopo avermi chiesto se mi serve un orologio, del tutto incurante del mio "...ma anche no, grazie" e pur mostrandogli il Citizen che ho al polso mi propone mirabolanti "orologi americani ultimo modello" dal valore di almeno 150 euro e che lui, ma solo perché gli sono simpatico per via del cane e perché una volta gli ho offerto un calice di rabosello, mi offre sottobanco per 10 euro. Quando gli faccio notare che orologi del genere si trovano in omaggio nei fustini del detersivo e che il logo CE sta per China Export, dunque, se proprio vengono dall'America, sono stati prodotti in qualche scantinato della China Town di Los Angeles o New York allora mi prende confidenzialmente sottobraccio e abbassando la voce perché altri non sentano me li propone a 5 euro, volendo anche in versione elegante da sera per la mia signora (immagino che se glielo comperassi l'elfa chiamerebbe il suo avvocato all'istante per iniziare la pratica di divorzio)
Ma, in realtà, non del tutto perché all'interno del bar staziona spesso una persona con la quale proprio non riesco a comunicare. Si tratta un vecchietto che, se non fosse male in arnese, sembrerebbe la copia conforme, occhiali scuri compresi, di Lionel Twain, il miliardario eccentrico di "Invito a cena con delitto". Ogni volta che mi vede entrare si avvicina con fare furtivo e, dopo avermi chiesto se mi serve un orologio, del tutto incurante del mio "...ma anche no, grazie" e pur mostrandogli il Citizen che ho al polso mi propone mirabolanti "orologi americani ultimo modello" dal valore di almeno 150 euro e che lui, ma solo perché gli sono simpatico per via del cane e perché una volta gli ho offerto un calice di rabosello, mi offre sottobanco per 10 euro. Quando gli faccio notare che orologi del genere si trovano in omaggio nei fustini del detersivo e che il logo CE sta per China Export, dunque, se proprio vengono dall'America, sono stati prodotti in qualche scantinato della China Town di Los Angeles o New York allora mi prende confidenzialmente sottobraccio e abbassando la voce perché altri non sentano me li propone a 5 euro, volendo anche in versione elegante da sera per la mia signora (immagino che se glielo comperassi l'elfa chiamerebbe il suo avvocato all'istante per iniziare la pratica di divorzio)
Nonostante i miei rifiuti ostinati in questi mesi mi sono visto proporre di tutto, sempre di provenienza americana e al prezzo amichevole di 10 euro (ma con te voglio rovinarmi e arrivo a 5) e fino al patto tra gentiluomini del: "Tu lo provi per qualche giorno e se ti piace me lo comperi, di te mi fido...". Qualche tempo fa, malgrado gli avessi detto subito di non essere interessato al genere avendo da un lato ancora una discreta vita coniugale e, dall'altro, potendo eventualmente trovare di tutto su internet gratis e pure con virus in omaggio, ha tirato fuori con aria complice dalla sua valigetta sdrucita dei DVD, sempre di provenienza americana e di ultimissima produzione, con la compianta Pozzi Moana e la pensionata settantenne Staller Ilona, in arte Cicciolina, che più che dei porno dovevano essere delle sedute spiritiche al geriatrico. Avendo la cosa oltrepassato i limiti, pur assai ampi, della mia sopportazione gli ho detto senza tanti giri di parole che ero stanco di tutte quelle sue proposte tarocche e che gradivo far colazione in pace. Così per qualche tempo è stato alla larga, limitandosi ad un cenno di saluto. Ieri mattina, ritrovato il coraggio, mi ha riavvicinato chiedendomi: "Ti servono occhiali?" e al mio deciso "Grazie, no. No, grazie! Come vedi non li porto..." ha continuato imperterrito "Ho degli occhiali americani ultimo modello, che in negozio li trovi almeno a 200 euro, ma a te li vendo a 10 euro".
"Guarda, ti ringrazio, ma come ti ho detto e forse ti è sfuggito, non uso gli occhiali... comunque, se non ti dispiace ora vorrei prendere il caffè prima che si freddi"
Non faccio a tempo a portare la tazzina alla bocca che lui mi trattiene per il braccio e sussurrando con aria complice mi dice: "Ho anche degli occhiali da sole meglio dei Rayban, li vuoi vedere? Sono polarizzati e anti riflesso... puoi usarli anche per sciare"
Scosto con fastidio la sua mano dal braccio (odio essere toccato dalla gente) e riesco a bere il caffè che era ormai tiepido.
"Occhiali da sole in inverno? Buona fortuna se pensi di venderli... comunque no, non mi interessano e non scio e ora lasciami fare colazione in pace perché stai iniziando ad infastidirmi"
Lui bofonchia un "Come che te vol..." e si allontana verso l'uscita mentre finalmente posso addentare la brioche, ma una volta sulla porta si volta di nuovo verso di me, come colto da un pensiero improvviso e mi fa: "Hai già pensato ai regali di Natale per tua moglie?"
Deglutisco a fatica il primo boccone della brioche respingendo a fatica l'istinto omicida. "Oddio... cosa hai ancora da proporre? Se sono accendini, ti avviso che mia moglie ha già il suo Dupont e non è interessata, quindi ciao e buona vita..."
"Peccato, perchè, casomai li avessi voluti, potevo trovarti degli Zippo originali americani. Comunque, volevo dirti che mi sono arrivate delle collane e degli orecchini con veri brillanti Swarovski, tutta roba di altissima qualità che in negozio la trovi a 200 euro, ma a te posso fare 10 euro..."
A quel punto la mia reazione verbale non è stata coerente con il consueto bon ton e quindi la lascio alla vostra immaginazione, anche se, a ben pensarci con il senno di poi, per dei gioielli con veri brillanti Swarovski a dieci euro, magari avrei potuto farci un pensierino... non vi pare?
"Guarda, ti ringrazio, ma come ti ho detto e forse ti è sfuggito, non uso gli occhiali... comunque, se non ti dispiace ora vorrei prendere il caffè prima che si freddi"
Non faccio a tempo a portare la tazzina alla bocca che lui mi trattiene per il braccio e sussurrando con aria complice mi dice: "Ho anche degli occhiali da sole meglio dei Rayban, li vuoi vedere? Sono polarizzati e anti riflesso... puoi usarli anche per sciare"
Scosto con fastidio la sua mano dal braccio (odio essere toccato dalla gente) e riesco a bere il caffè che era ormai tiepido.
"Occhiali da sole in inverno? Buona fortuna se pensi di venderli... comunque no, non mi interessano e non scio e ora lasciami fare colazione in pace perché stai iniziando ad infastidirmi"
Lui bofonchia un "Come che te vol..." e si allontana verso l'uscita mentre finalmente posso addentare la brioche, ma una volta sulla porta si volta di nuovo verso di me, come colto da un pensiero improvviso e mi fa: "Hai già pensato ai regali di Natale per tua moglie?"
Deglutisco a fatica il primo boccone della brioche respingendo a fatica l'istinto omicida. "Oddio... cosa hai ancora da proporre? Se sono accendini, ti avviso che mia moglie ha già il suo Dupont e non è interessata, quindi ciao e buona vita..."
"Peccato, perchè, casomai li avessi voluti, potevo trovarti degli Zippo originali americani. Comunque, volevo dirti che mi sono arrivate delle collane e degli orecchini con veri brillanti Swarovski, tutta roba di altissima qualità che in negozio la trovi a 200 euro, ma a te posso fare 10 euro..."
A quel punto la mia reazione verbale non è stata coerente con il consueto bon ton e quindi la lascio alla vostra immaginazione, anche se, a ben pensarci con il senno di poi, per dei gioielli con veri brillanti Swarovski a dieci euro, magari avrei potuto farci un pensierino... non vi pare?